di Daniele Orso
da Nella spirale (Stagioni di una catastrofe) (Industria&Letteratura, 2021)
Nella spirale della catastrofe odierna
“In che modo parlare la lingua dei carnefici può contribuire a porre fine alla tortura? È dubbio se anche solo possa aumentare la consapevolezza della tortura”: scrivevo qualche settimana fa su un noto social ormai passato di moda. “Lo straniamento è il punto. E in ogni caso è meglio lo straniamento che la mimesi”: rispondeva quello giustamente. Certo, molto meglio ribaltare lo specchio contro Calibano, servire il pasto nudo ai commensali, piuttosto che fingere o, peggio ancora, credere che siamo stati invitati a una deliziosa cena di gala. L’orchestrina che suona è quella del Titanic, è la tristezza degli organetti della Galizia mentre mezza Europa bruciava e gli stessi spettatori tra il pubblico deliziato scomparivano nel Maelstrom. Ma il punto è: cos’è mimesi e cos’è straniamento? Ripetere la propagandistica modulare costituita di slogan e refrain che ad ogni ripetizione perdono via via ancor di più il minimo spolverio di senso di cui debolmente erano rivestiti, è straniamento? Costituisce un’arma efficace ad arginare il non-sense del Falso (Falso che sostituisce fittiziamente e surrettiziamente il Reale, fake di un core reale ormai non più verificabile né rintracciabile)? O non cede e resiste chi invece ha già ceduto, chi ripropone gusci di forme vuote a ricordare un tempo in cui quelle forme si accompagnavano a un pieno di vita? Nessuno dopo Auschwitz potrebbe leggere un sonetto senza percepire la parodia delle forme. Soltanto il filologo ormai può leggere il Foscolo come lo stesso Foscolo leggeva se stesso. Noi no, non più. Tutte le forme neo-metriche o neo-metricistiche non sono altro che la riproposizione di cadaveri nella sfiducia che la salma sia mai stata viva. Ma non sono mere esibizioni macabre da snuff movie di serie B. Più forte resisterà chi si è già lasciato andare. La sfiducia nella parola (poetica) come conditio sine qua non per poter scrivere poesia nei tempi attuali. Abbiamo fallito, non possiamo continuare, continueremo. Sono pensieri che fatalmente si pone chiunque prenda la penna o ponga le dita sopra una tastiera nell’atto di scrivere. Chiunque lo faccia con un certo grado di consapevolezza. Avanguardia e tradizione. Dove la “e” è sia disgiuntiva che congiuntiva: davvero la sperimentazione entra in un rapporto dialettico (di un dialettica negativa, per la quale la sintesi è sempre rimandata da una negazione via via sempre più definitoria: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, ahimè, ancora) con la tradizione, non per riproporre cascami di materia morta bensì per custodire ciò che ha valore, in una ricerca perenne e sempre rimessa in discussione. Ogni punto è equidistante dal suo centro, ma il meccanismo non gira a vuoto, entra in un momento ben preciso per poi proseguire lungo una traiettoria non prevista: una spirale, insomma. Nella spirale, appunto, si intitola l’ultimo libro di Gianluca D’Andrea, pubblicato per Industria & Letteratura, il progetto di Gabriel Del Sarto e Niccolò Scaffai che, a circa tre anni dall’esordio nel panorama editoriale italiano ha già incassato un premio Viareggio con Quanti di Flavio Santi e, quel che più conta, il rispetto della comunità delle Lettere. D’Andrea ha già costruito una propria fisionomia con le raccolte Distanze (lulu.com, 2007), Chiusure (Manni, 2008), [Ecosistemi] (L’arcolaio, 2013), Transito all’ombra (Marcos y Marcos, 2016), Forme del tempo (Arcipelago Itaca, 2019). In Postille (tempi, luoghi e modi del contatto) (L’arcolaio, 2017), ha dato prova delle sue capacità critiche. Nella spirale si trova D’Andrea e con lui noi tutti, incastrati in una prolungata crisi economica, sanitaria, culturale ed etica; e dalla spirale D’Andrea scrive. Scrive senza speranza di trovare un’ancora, un porto sicuro ma proprio per questa di-sperazione, la parola esce rinnovata, veritiera seppure labile, fragile come l’ultima parola del condannato a morte. La lingua del post-umano: “è il rischio del margine, un cammino che si apre e si chiude tra parvenza e reale”. Ma proprio perché tutto sembra già avvenuto, il disastro sempre rinnovato e riprodotto, non resta che prenderne atto e rilanciare il verbo attraverso la coscienza dell’estraneità, della superfluità dell’uomo rispetto al mondo. La contemplazione di un mondo post-umano in cui ciò che c’è da salvare è proprio l’inermità dell’uomo davanti al mondo che si approssima (o si è ormai approssimato) a finire. E dall’oltremondo si fa spazio il bisogno di comunicazione con l’Altro: in un’epica di lockdown e di intimità esibita, di solitudini invalicabili, questi testi evocano la necessità di aprirsi all’estraneo da sé. Poesia come comunicazione estrema anche a dispetto della propria (non-)intenzione. Il “margine” ultimo come possibilità di apertura di uno spazio non previsto, non prevedibile né programmabile: “postazione isolata che ci attorciglia a noi, anzi a un Noi-Io ancora più “individualizzato”, alienato e “assoggettato” proprio quando il soggetto ha raggiunto la sua scomparsa”, e ancora (citando Burnside): “è qui che inizia il futuro: nell’oblio, in ciò che è perduto”. Margine, si diceva, ma margine – anche – come limite. Limite all’uomo, all’umano: oltre comincia il post-umano, l’oltre-umano (Nietzsche nume tutelare evocato e bagliore di una traccia da seguire). Oltre c’è soltanto la consapevolezza della finitezza dell’uomo, la necessità di rientrare nell’alveo della natura (Leopardi a costituire la seconda stella polare), in una impossibile, ma proprio per questo ineludibile, comunione in un unico “uomonatura”. Il cammino, il camminare come metafora dell’andare avanti nonostante l’assenza di una meta: “nel lock-in che generava una nuova/ appartenenza si sentiva appagato,/ tenero, nascente come un uomo/ raccolto nel suo attimo di rivelazione,/ nella sua notte del passato. Nell’avvenire”. La ciclicità come modello epistemologico, ciclicità della natura e delle stagioni. La raccolta è infatti cadenzata in quattro sezioni corrispondenti alle quattro stagioni. Si apre con la Primavera, presa di coscienza del proprio scacco, della necessità di oltrepassare il soggetto e si conclude con l’Inverno, presa d’atto dell’impossibilità di fuoriuscire dallo stallo senza offrire in sacrificio la propria (succedanea) identità. La regressione (o progressione distopica) filogenetica (nel primitivo) e ontogenetica (nell’infanzia) nella necessità di proteggersi da una natura ostile, “aspra”, “arida”, sempre involtolata in “spine”, “punte”, pungiglioni. Da qui la ricerca di riparo nelle profondità ime, nella “terra”, nel “fango” e nella “merda” , nel magma-mamma (ad un tempo scatologia, escatologia e regressione psicoanalitica nel ventre materno). Natura mater crudele a un tempo salvifica e minacciosa che costringe i piccoli e nuovi uomini alla consapevolezza della propria incessante spinta a godere, a desiderare. Un climax sempre via via frustrato, impedito e, proprio per questo, protratto. Elemento sotteso è la vista, vista annebbiata e ingannata che si apre al mondo (termine chiave dell’intera sezione è “l’occhio”, in tutte le sue declinazioni, ora anatomiche ora figurate). La meta è assente, è il nulla, l’oblio. Oblio della memoria e oblio dell’esistenza. Ci si muove per essere annullati nell’altissimo (o profondissimo) nihil naturale: “una morte vera di semi/ cosparsa sul sentiero”. Autunno è la “marcescenza”, la “decadenza”, il “declino” rovinoso e rugginoso, il colare umido di umori da cadaveri di sé, in uno stato di non-vita, “morte in vita”, di zombismo psichico prima ancora che fisico, sebbene la pandemia evocata risuoni le sue cadenze di morte molto concreta e tangibile. La “crepa” come spirito-guida, muri crepati e crepe del terreno. E, da contraltare, tutta una tassonomia botanica di tigli, querce, aceri, faggi, castagni, larici, in un rispecchiamento metamorfico della “stagione <<vegetaliforme>>” e larvale (la carcassa liminare alla larva, il brulichio di camposanto degli insettini che macerano l’organico). I pochi uomini che transitano sono spettri di uomini, funzioni di contrasti dialettici: “falegnami e youtuber, tiktoker e contadini, nun with gun e cybermonk al canto di un sogno sempre presente cantato in lipsync”. Un’apparente stagnazione di liquidi colanti che lascia presagire una trasformazione organica, una mescidazione verbale in cui il termine dialettale e materno si mescola all’approssimato e transnazionale inglese ipertecnologizzato di latina matrice: “<<quannu accumènza la vita nasci la morti>> e quando comincia la morte si sporgono gli ibernauti e il gelo si avvicina”. La stasi, la concrezione della forma, del “silenzio in forme chiuse”: per poter procedere si deve aver perso ogni idea di movimento, di progressione. Fine ultimo del cammino è la fine. Una scomparsa definitiva e zen di ogni ipotesi di movimento. L’inverno è la sezione più potentemente agghiacciante, inquietantemente immobile. La perfezione formale e siderea che indica in forma spettrale un futuro già passato, un orizzonte di immobilità e nullità. Assenza di moto, privazione di ogni concetto: “a senti l’eco du nenti?”. Se nelle sezioni precedenti la versificazione poetica lasciava il campo a una scrittura rizomatica, informale (lacerti di versi-proposizioni, di versi-frasi) che inseguiva il movimento organico del soggetto, nell’ultima sezione, il movimento è abolito, resta solo il guscio di una forma perfetta (terzine di endecasillabi perfettamente rimati, per lo più aggregate in una forma di madrigale o di sonetto breve, composto di due terzine e di una chiusa lapidaria in distico) senza soggetto, né sviluppo. Il linguaggio statico della perfezione formale è costituito da dantismi (s’inseria) – via via indietro fino alla scuola siciliana – e termini mutuati dalle scienze, dalla biologia o dalla fisica (pallido sfregio di cellule) in un’amalgama finalmente senza avvenire né futuro: l’alfa e omega della lingua, di per sé conclusa e imperfettibile. E alla fine del nostro viaggio ritorniamo al nostro inizio. Cos’è mimesi e cos’è straniamento? Lo shock dilaniante di una perfetta e cristallina presa d’atto del niente (nihil supremo) in cui siamo immersi è lo straniamento mimetico del pensiero che chiarifica il suo rapporto col mondo? Forse è solo l’unico atto possibile, Munchausen che si solleva afferrandosi dal codino per uscire dalla palus putredinis in cui è affondato, come recita la sestina conclusiva: “forse è un’ultima luce il desiderio/ che nuovi dei scandagliando la notte/ scopriranno sotto crepe di ghiaccio./ La terra è vostra, correte altro mare/ naufraghi carezzati da stagioni/ inedite, diverse come l’aria// che respirate. D’Andrea, puntellandola con gli spunti offerti da numerosi autori-fratelli spirituali evocati lungo tutto il libro, scrive un’opera all’altezza dei tempi attuali, che si interroga sul senso del proprio fare e sui nostri destini umani.
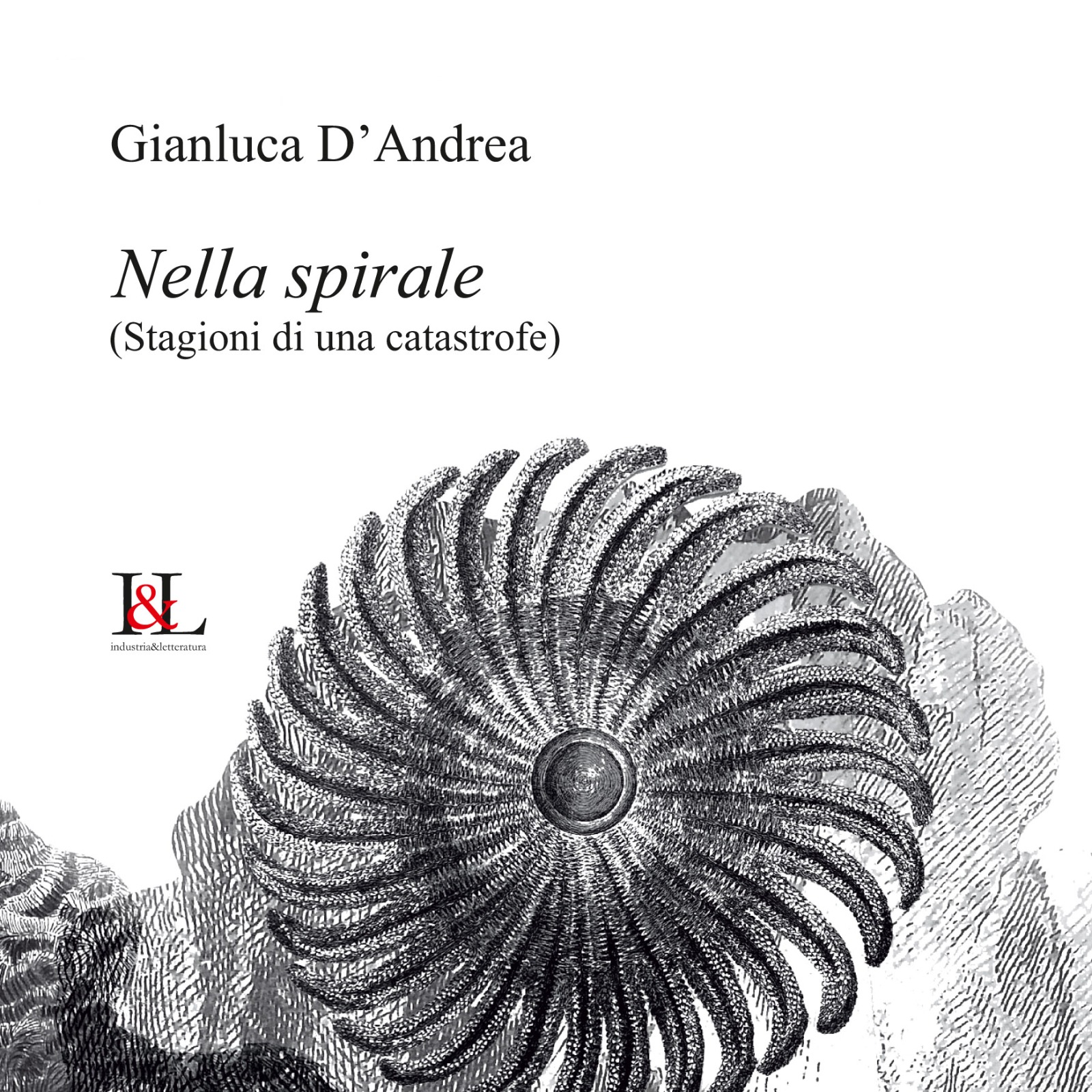





Rispondi